
Michela Murgia ha chiuso gli occhi. Una delle voci narrative più controverse e divisive degli ultimi anni ci ha lasciato.
Il tempo migliore della mia vita. Un brutto male, quello che oggi falcia migliaia di persone, le ha presentato un costo salato, non le ha dato scampo. Ma ciò che mi resterà impresso, oltre al suo essere una delicata quanto forte scrittrice, sono la forza e la dignità dimostrate davanti ad una sentenza inappellabile. Non vi è stata disperazione, ma accettazione della morte, una delle cose più difficili da fare, secondo me, per l’essere umano.
Accabadora
È con il libro “Accabadora”, pubblicato nel 2009 e vincitore del Premio Campiello, che ho conosciuto questa scrittrice. Un libro, e non lo dico solo perché l’articolo parla di lei, che mi ha colpito. Un romanzo dal sapore etno-antropologico che mi ha fatto conoscere un tipo di matriarcato che ancora fino all’inizio del secolo scorso imperversava in Sardegna. Una sorta di eutanasia umana, come mi piace definirla. Di lei, dopo non ho letto altro, ma questo libro mi ha, in qualche modo, segnato in un modo che ancora oggi non riesco a definire.
Questo articolo non è pensato come omaggio a questa scrittrice di cui, nonostante tutto, sentiremo parlare in futuro ma è la riflessione su quanto detto da lei in una intervista per Vanity Fair. Qui non voglio spiegare perché la sua eredità culturale ha sempre diviso l’opinione pubblica, sul perché la sua libertà d’espressione abbia spesso scatenato dibattiti di natura politica e sociale. Qui voglio raccontare perché quando ho sentito le sue parole durante l’intervista, ho deciso di scrivere. Mi ha fatto comprendere che la felicità sta nell’attimo, in un sorriso, in un abbraccio. La felicità non è sempiterna ma è racchiusa nelle piccole cose. La vita può essere meravigliosa perché abbiamo il potere di plasmarla con la nostra creatività e i nostri desideri. Purtroppo, però, oggi, siamo sempre meno in grado di leggere la felicità che ci passa accanto e sulla bilancia vince sempre il dolore, il più lungo da smaltire, così come affermava anche secoli fa Leopardi. La felicità non ha definizione, ognuno di noi ne ha una personale in linea con il proprio modo d’essere ma, per poterla afferrare, dobbiamo imparare a guardare.
Il suo testamento morale
«Io non mi sono mai rassegnata a pensare che non mi spettasse la felicità. Ci ho provato ogni giorno. Quando mi dicevano: “Tu che cosa vuoi fare nella vita”, rispondevo non lo so, ma voglio essere felice. Questo mi ha permesso di fare dieci lavori e di non smettere mai di essere felice. Io avrei potuto insegnare tutta la vita. Sarei stata comunque la persona che sono. Una cosa resta importante: riconoscere la felicità è una forma di intelligenza. Perché molte volte la felicità ti passa accanto e tu non capisci che quello è un momento felice. Perché sei troppo presa o stanca. Ho avuto fortuna perché il mio tipo di lavoro mi permette un’introspezione e delle pause in cui posso guardare me stessa dall’esterno e in cui capisco che il tempo che sto vivendo è probabilmente il tempo migliore della mia vita. Io oggi dico: questo è il tempo migliore della mia vita. Visto da fuori non lo è: ho il cancro, ho il tempo contato, come tutti del resto, ma io ho il conto più breve. Dovrebbero essere elementi di non felicità. Ma invece non conta il cosa, conta il come. E in questo momento io posso scegliere il come»
È Michela che chiude questo mio articolo. Non potevo fare altrimenti. Grazie Michela, che la terra ti sia lieve tanto da scrivere anche da lassù. Buon viaggio nell’infinito!
Link per l’acquisto: ACCABADORA


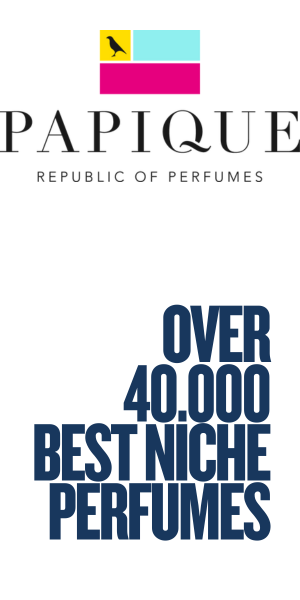


Comments are closed.