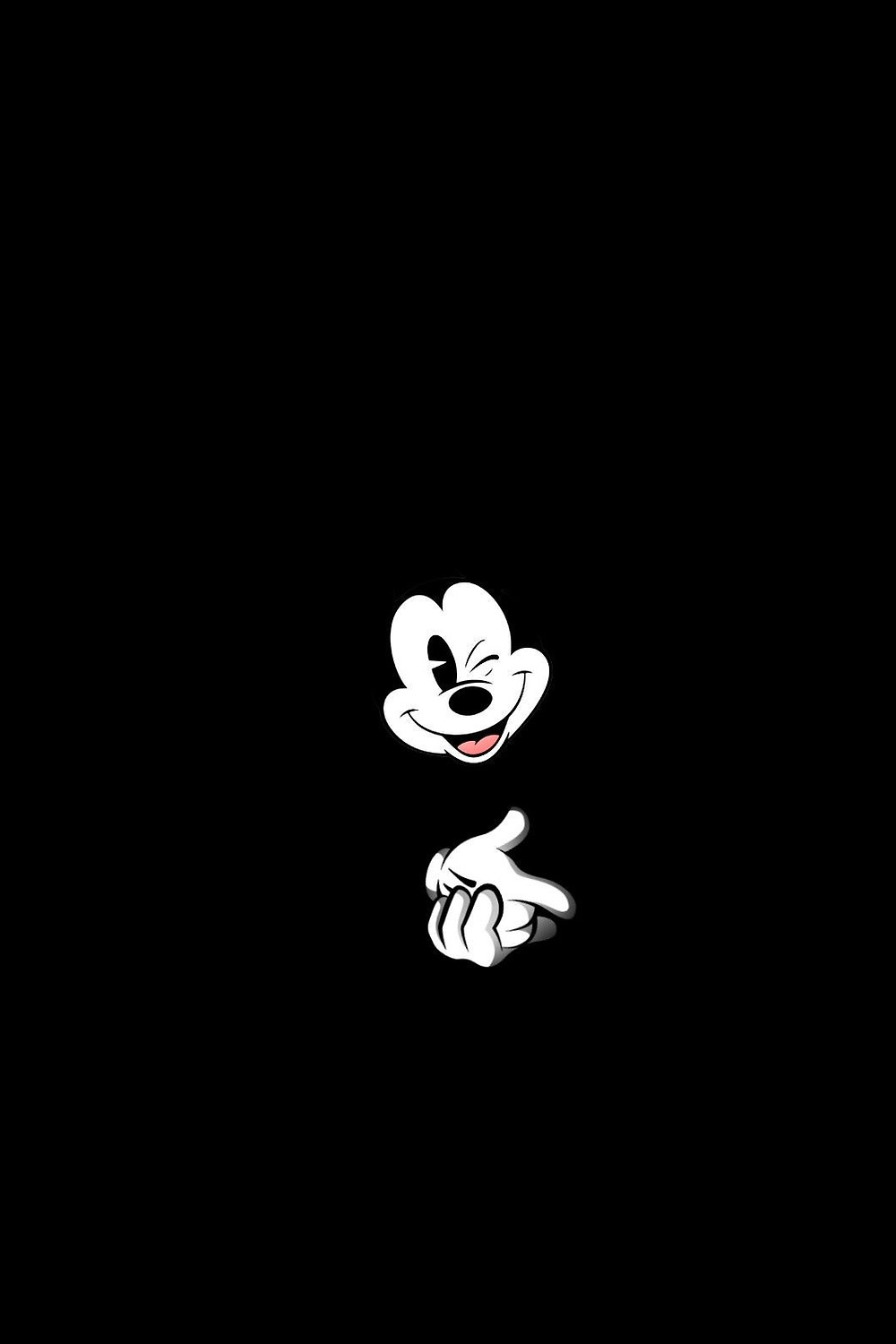
Castelli incantati, bellissime principesse, principi in scintillante armatura su candidi destrieri, sortilegi da spezzare, il bacio del vero amore e il “vissero per sempre felici e contenti”. Questi sono gli ingredienti dei film d’animazione Disney che ci hanno fatto tanto sognare durante la nostra infanzia. Ma le fiabe originali dalle quali la Disney ha preso spunto sono tutta un’altra storia.
Come sappiamo, i prodotti d’animazione Disney sono fatti principalmente a misura di bambino. Ma è anche vero che la Disney si è da sempre ispirata, durante il processo di ideazione e creazione dei suoi intramontabili capolavori, a racconti, miti e leggende facenti parte del patrimonio culturale, letterario e folkloristico del nostro immaginario. Un patrimonio decisamente più macabro, disturbante e oscuro rispetto ai colori pastello e alle atmosfere zuccherose dei classici disneyani.
Biancaneve e i sette nani (1937)
“Biancaneve e i sette nani” ha rivoluzionato la Storia del Cinema: è stato il primo film d’animazione prodotto negli Stati Uniti d’America, il primo a essere girato completamente a colori e il primo lungometraggio prodotto dalla Walt Disney Productions (il che ne fa il primo Classico Disney, secondo il canone ufficiale).
La storia di Biancaneve è basata sull’omonima fiaba dei fratelli Grimm. Una fiaba che definirla macabra è un eufemismo. Cannibalismo rituale, necrofilia e sadismo sono i protagonisti della vera storia di Biancaneve.
Così come nel classico Disney, anche nella fiaba dei Grimm, Biancaneve è una principessa rimasta orfana. Ma se nel primo caso possiamo notare che la fanciulla ha più le fattezze di un’adolescente, nel secondo caso Biancaneve è una bambina di appena sette anni.
Invidiosa, la matrigna ordina al cacciatore di ucciderla. Ma perché la matrigna vuole uccidere una bambina di sette anni? La riposta ce la dà il professor Silvano Petrosino nel suo libro “Le fiabe non raccontano favole”.
Nel cartone Disney viene data come “giustificazione” l’invidia della bellezza da parte della matrigna nei confronti di Biancaneve. Ma da un punto di vista più profondo, ciò che la matrigna odia in Biancaneve è il suo fiorire, il suo diventare donna e, soprattutto, madre: cosa che la matrigna non potrà più essere una volta passata l’età fertile.
Il tema della cosiddetta “maternità negata” porta inconsciamente la matrigna a desiderare la morte della piccola Biancaneve.
E, per questo, chiede al cacciatore di portarle il fegato e i polmoni della bambina come prova della sua morte. Il cacciatore le dà, invece, le viscere di un maiale e la regina mangia gli organi con gusto. Questo è ciò che in antropologia viene chiamato “cannibalismo rituale”: mangiando gli organi del nemico, si assimila al contempo anche la sua forza.
Quindi, credendo di mangiare gli organi di Biancaneve – la sua nemica – la matrigna crede di poter ritornare giovane, bella e fertile.
Altro elemento iconico del lungometraggio Disney è la mela avvelenata. Nella fiaba originale, la mela avvelenata rappresenta però l’ultimo stratagemma messo in atto dalla regina per uccidere Biancaneve.
La matrigna, infatti, cerca di uccidere la bambina tre volte. Prima le stringe il corsetto talmente stretto da farla svenire. Poi le spazzola i capelli con un pettine avvelenato che la fa cadere in un sonno simile alla morte ma quando i nani rimuovono il pettine, lei si risveglia. Infine, Biancaneve mangia la mela avvelenata che la fa piombare in uno stato di morte apparente.
A questo punto, i nani ripongono il suo cadavere in una bara di vetro che un principe trova e decide di portare a casa con lui (uno che si porta al castello come souvenir il cadavere di una bambina in mezzo al bosco proprio normale non è).
Ma a differenza di ciò che vediamo nel classico Disney, qui Biancaneve non si risveglia grazie al bacio del principe. Mentre la bara viene spostata, il pezzo di mela cade dalla gola di Biancaneve e lei si sveglia. Niente bacio del vero amore.
Nonostante questo, i due decidono di sposarsi e al matrimonio invitano anche la regina, la quale viene costretta ad indossare scarpe di ferro bollenti e fatta ballare fino a quando morte non sopraggiunga.
Quella dei Grimm non è, però, l’unica versione esistente. I due fratelli tedeschi, infatti, si ispirarono a loro volta a un racconto dell’italiano Giambattista Basile scritto nel 1634 e intitolato “La Schiavottella”.
In questa storia, su una bambina grava una maledizione che la porterà a morire nel suo settimo anno di vita. Quando la bambina compie sette anni, la madre le sta pettinando i capelli e il pettine si conficca nel cranio della ragazza, uccidendola apparentemente.
La madre la mette in sette bare di cristallo, poste l’una dentro l’altra, e la nasconde in una camera nel castello. La madre alla fine muore di dolore e affida la chiave della stanza al fratello, zio della bambina, dicendogli di non aprire la porta.
La moglie del fratello si impossessa della chiave, apre la porta e trova una bellissima giovane donna dentro le bare di vetro (la ragazza ha continuato a crescere mentre dormiva).
Pensando che il marito stia mantenendo la ragazza chiusa in camera per avere rapporti con lei, la trascina fuori per i capelli, rimuovendo il pettine e rompendo l’incantesimo. La moglie le taglia la chioma fluente e la frusta a sangue con i suoi stessi capelli.
Fa poi della ragazza la sua schiava e la picchia ogni giorno, rendendo i suoi occhi neri e la sua bocca così sanguinolenta da far sembrare che fosse stata mangiata dai piccioni. La ragazza decide di uccidersi, ma mentre affila la lama del coltello, racconta la sua storia a una bambola.
Suo zio ascolta e la trama si rivela. Caccia quindi la moglie, cura la nipote, e poi la dà in moglie ad un uomo ricco.
Beh, insomma… tutto è bene quel che finisce bene, come si suol dire!
Cenerentola (1950)
Con l’uscita di “Cenerentola” si impone definitivamente il concetto di Classico Disney. Come “Biancaneve i sette nani”, anche questo lungometraggio è ispirato a una fiaba europea: “Cenerentola” di Charles Perrault.
Il racconto di Perrault risale al 1697 ed ha uno sviluppo narrativo molto simile a quello adattato dalla Disney. Tuttavia non mancano elementi cruenti.
Infatti, sia la versione di Perrault, sia quella successiva dei fratelli Grimm (in cui le sorellastre si auto-mutilano i piedi per poter indossare la scarpetta, venendo poi rese cieche dagli uccelli incantati di Cenerentola) contengono elementi de “La Gatta Cenerentola” (1634) di Giambattista Basile.
Qui Cenerentola confida alla sua governante, apparentemente gentile, la crudeltà della sua matrigna. La governante le consiglia di risolvere il suo problema uccidendo la matrigna. Cenerentola lo farà rompendole il collo.
Cenerentola convince quindi il padre a sposare la governante. Si scopre però che quest’ultima nascondeva sette belle figlie e, una volta venute allo scoperto, il padre di Cenerentola perde interesse per la propria figlia.
Tutti iniziano a maltrattarla, abusando di lei e viene mandata nelle cucine a lavorare come serva. Qui le daranno il soprannome di ‘Gatta Cenerentola’ (in precedenza il suo nome era Zezolla).
Il resto della storia procede come il classico Disney e termina con un lieto fine a tutto tondo. Tuttavia, sapere che Cenerentola si sia macchiata dell’omicidio della matrigna non ci fa fare sogni proprio tranquilli.
Ritornando per un attimo al lungometraggio della Disney, la figura di Cenerentola è stata oggetto di studi di tipo psicologico.
Cenerentola ci viene presentata come una ragazza di buoni sentimenti, remissiva e decisamente incline al sacrificio: non si è mai sottratta al crudele sfruttamento impostole dalla matrigna e dalle sorellastre.
In psicologia, si parla di “complesso di Cenerentola” per indicare quelle donne che sviluppano una dipendenza affettiva patologica. Accanto a questa caratteristica, si affianca la credenza che soltanto il “principe azzurro” potrà aiutarle a realizzare i propri desideri.
Alice nel Paese delle Meraviglie (1951)
Tredicesimo classico Disney, “Alice nel Paese delle Meraviglie” non è basato (come i lungometraggi precedenti) su fiabe popolari ma sull’opera dello scrittore e matematico vittoriano Lewis Carroll, “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” (1865).
L’opera di Carroll non ha nulla di macabro, scabroso e dissacrante. Ma ciò che ci fa guardare il film con occhi diversi è l’interpretazione “psicopatologica” che è emersa nei confronti del personaggio di Alice.
La dolce Alice è stata, infatti, immaginata come in preda a un disturbo psicotico, in particolare al disturbo schizoaffettivo. I Disturbi Psicotici si caratterizzano per una drastica perdita di contatto con la realtà.
Per questo, esperti del settore si sono domandati: ma se il lungo sogno di Alice, popolato dallo Stregatto, dal Brucaliffo e da fiori che cantano, fosse stata un’esperienza allucinatoria?
Nello specifico, il disturbo schizoaffettivo si distingue per allucinazioni, deliri e, soprattutto, alterazioni dell’umore. Quest’ultimo può manifestarsi in stati maniacali (umore estremamente alto) o depressivi.
Non è difficile, infatti, ricordare momenti in cui la protagonista è incredibilmente entusiasta e sovra-eccitata o, al contrario, terribilmente scoraggiata e in preda – letteralmente – a fiumi di lacrime.
Ovviamente, questo tipo di interpretazione non ha la pretesa di essere universalmente condivisa e accettata ma offre in ogni caso uno spunto di riflessione interessante e ci fa comprendere la grande profondità e ricchezza dei racconti e dei film per l’infanzia.
Nel prossimo articolo di questa mini-rubrica, continueremo il nostro viaggio tra i meandri oscuri dei classici Disney!
Fonti
Il lato oscuro delle favole: i veri finali prima della Disney
5 sindromi Disney: quando dietro un personaggio si nasconde un disturbo


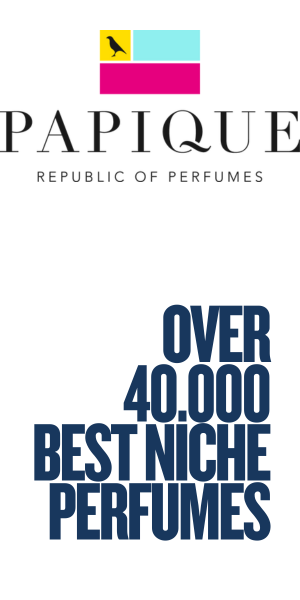


Comments are closed.