
È un’operazione affascinante quella di entrare nel regno sfumato che separa realtà e finzione.
Vera, il film di Tizza Covi e Rainer Frimmel, con protagonista Vera Gemma, vincitore del premio Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia 2022, ci porta al confine tra questi due mondi – un confine labile che si ridefinisce costantemente. In questo caso particolare ha il grande merito di essere il metodo quasi necessario per affrontare la storia (paradossale) di una donna che è nata dentro al grande macchinario del cinema, cresciuta sui grandi set dei western, e, in cambio, ne è rimasta sempre esclusa.
Ci sono grandi verità in Vera.
Una mimesi aristotelica dove troviamo personaggi che parlano senza seguire la sceneggiatura (che non conoscono propriamente ma solo abbastanza da potersene fidare). Girato cronologicamente, dando così il tempo necessario alle relazioni che vediamo sullo schermo di svilupparsi realmente tra gli attori, nella realtà al di qua dello schermo; il ritratto di Vera diventa emblematicamente ricerca di verità per i tanti mondi che mostra, sfiorandoli appena talvolta, o raccontandoli nella loro interezza in poche scene.
“Più somiglio a una trans più mi sento bella. La conosci Eva Robin’s?” sono queste le prime battute del film – che contengono già in nuce le tematiche principali in tutta la loro complessità.
L’ossessione per la bellezza; il femminile al maschile; un femminile che cerca di sdoganarsi dal maschile. Ossessione estetica che diventa paragone continuo: ai tanti provini a cui Vera si è presentata le è stato detto che non era bella quanto il padre, Giuliano Gemma. Lei e sua sorella Giuliana hanno vissuto all’ombra del mito, non sentendosi mai abbastanza. Da giovanissime, la madre le ha convinte a rifarsi il naso. “Avevamo dei nasini così carini ma perché ci hanno fatto fare quell’operazione?”, si chiedono mentre riguardano le foto d’infanzia in una delle rare scene del film che le vede insieme. “Papà ci ha distrutto i rapporti con gli uomini”, confessano. In qualche modo viziate da tanta bellezza e attenzione, non sono mai riuscite a trovare un altro come lui.
Il paragone costante con la figura del padre, un maschile affermato, il cui spirito gode ancora di fama, è fonte costante di insicurezze.
In pochi minuti impariamo a conoscere Vera; è generosa, tanto, tanto che il pregio diventa difetto. Nel dare e nel darsi perde di vista se stessa, le sue qualità e i suoi diritti. Paga l’affitto alla famiglia alla quale si lega, dopo un incidente in auto. Dopo essere stata menata non denuncia: “si tratta di un episodio della sua vita; lui cambierà.” Quante donne rispondono così agli atti di violenza?
Quante donne vivono nell’ombra di un maschile?
Vera, raccontando se stessa, racconta un mondo che cerca di cambiare. Un femminile che cerca di affermarsi all’interno di un universo che è stato costruito e declinato al maschile.
E per quanto Vera possa sentirsi sola in questo cammino, lei e le sue verità descrivono un universale in extremis – nel quale tutte le donne possono ritrovare atteggiamenti e convinzioni che, se non hanno ancora avuto modo di superare, si ritrovano a combattere quotidianamente.
È più forte e più convincente parlare per metafore e allegorie piuttosto che per verità. Vera si mostra nella sua essenza e il difetto diventa pregio proprio perché ci viene mostrato.
Il clima intimo del set d’altronde ha permesso un’indagine ravvicinata: presenti solo i due registi insieme all’assistente alla regia, che ha anche una piccola parte nel film.
Il primo piano del padre incorniciato sopra il letto matrimoniale è l’immagine più eloquente del film. Sdraiati sotto “l’icona”, il fidanzato Gennaro chiede a Vera dei soldi per continuare il film che sta dirigendo. Soldi e contatti, non a caso proprio quello di Monica Bellucci, considerata una delle donne più belle del mondo. La bellezza, come la fama del padre, sembra essere ostacolo costante all’affermazione del proprio sé.
Asia Argento accompagna Vera nel cimitero acattolico di Roma per vedere la tomba del figlio di Goethe; un’anima che riposa in pace senza identità. “I figli di” che non hanno nome proprio; non sono stati riconosciuti come individui, non hanno avuto diritto di parola. La lotta per il proprio nome diventa parallelamente, foneticamente ed essenzialmente lotta per la propria verità.
È un film, d’altronde, che porta insieme tante realtà, alcune incontrate per caso, altre cercate con convinzione. Un collage di realismo cucito da performance che si basano sul proprio concetto di identità, che è ricerca costante.
All’incontro con la stampa, Tizza Covi ha raccontato di una fortuita conversazione avuta su un treno diretto a Napoli, “Ho conosciuto un uomo che si è presentato dicendo che era un truffatore di assicurazioni. Quindi gli ho chiesto più dettagli per informarmi, che ho poi usato per la sceneggiatura. La truffa assicurativa del film è frutto di quest’incontro avvenuto in treno.”
Le citazioni cinematografiche, da Sergio Leone allo Scarface di De Palma; da Stanlio e Olio a Franco Citti, fino ad arrivare al palazzo di Amarcord, sono lo sfondo dell’universo meta-cinematografico della protagonista. Tizza Covi parla “del forte legame che Vera ha con il cinema e che la città di Roma ha con il cinema”. Roma è il set perfetto; Vera è stanca di presentarsi ad altri provini, ha bisogno di persone vere; il bisogno di realtà a cui tutti aspiriamo.
“Essere se stessi è la grande rivoluzione oggi”, ha detto Vera all’incontro.


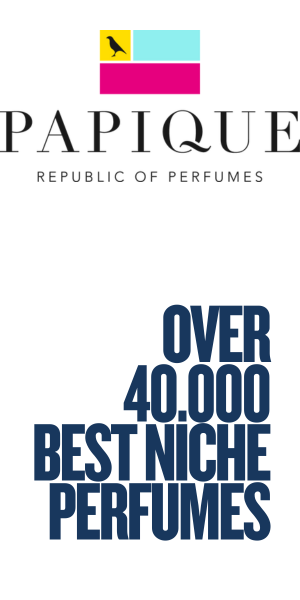


Comments are closed.