Paolo Giordano, Nel contagio, Einaudi – Corriere della Sera, pp.63
Questa non è e non vuole essere una recensione, quanto piuttosto una riflessione per la quale sono debitrice a Paolo Giordano. Il 26 marzo, allegato al «Corriere della Sera», è uscito il suo Nel contagio, un pamphlet capace di fare ordine tra una serie di questioni sulle quali credo sia di vitale importanza interrogarsi in questo momento.
Non tutte le tragedie – e questa pandemia lo è – ci rafforzano. Ho la sensazione che questa ci indebolirà. Ma di certo le tragedie possono almeno lasciarci con delle consapevolezze in più: mettendo a nudo alcuni nostri aspetti, possono obbligarci a prenderne atto. La paura, per citare Giordano, non può passare invano, «senza lasciarsi dietro un cambiamento». L’emergenza sanitaria deve renderci almeno consapevoli di quello che siamo o siamo diventati.
Personalmente mi sembra di avere messo a fuoco almeno due dati di fatto, da cui conseguono altri.
Il primo: non siamo più abituati a pensare alla previsione come a una forma di intelligenza o come a un aspetto della nostra intelligenza. Viviamo nel tempo breve di una finestra di internet che si apre e si chiude, leggiamo qua e là secondo la regola del mordi e fuggi, passiamo superficialmente di pagina in pagina ma l’approfondimento ci è estraneo. Abbiamo quindi perso l’abitudine al calcolo, all’analisi e siamo meno abituati a prevedere conseguenze di azioni che non riguardino l’immediato domani.
Il secondo: la separazione tra cultura umanistica e cultura scientifica si è acuita sempre di più. Certamente il pregiudizio crociano secondo cui la scienza non produce conoscenza ma solo sapere tecnico (gli esperti di Croce mi perdoneranno la semplificazione) ha avuto un peso determinante in Italia, relegando la scienza a pseudo concetto e fornendo agli umanisti la scusa per allontanarsene. Ma questa crisi ci mette di fronte al danno legato alla svalutazione del sapere scientifico, alla “destituzione” della competenza. Salvo poi, in un’inversione di rotta dettata dallo spavento, farci salutare come salvatore chiunque riesca a elaborare e analizzare dei dati fornendoci informazioni che non siano opinabili.
Su queste evidenze generali, che l’emergenza ha svelato, mi pare ci sia accordo. Poi ci sono delle consapevolezze più individuali, personali, ma altrettanto importanti, e che il libro di Giordano mi ha aiutato a mettere a fuoco. Procedo con ordine, seguendo l’esempio di Giordano stesso, compilando, proprio come ha fatto lui in un articolo sul «Corriere della Sera», una sorta di lista (la mia molto più breve).
1.«In certe situazioni il solo coraggio possibile è quello di rinunciare» (p.21). Mi sono chiesta perché ho attraversato una fase che non esito a definire di estrema stupidità. La fase in cui mi sono ostinata a pensare e a dire che avevamo a che fare con una febbre come tante altre, che tutto sarebbe tornato normale. Anche quando, già dal 26 febbraio, utilizzavo sui mezzi di trasporto una mascherina chirurgica su consiglio di un’amica medico (alle regole che “chi sa” mi indica, io non so sottrarmi), pensavo che fosse inutile e quasi mi sentivo ridicola in mezzo agli altri che non la indossavano. Perché, mi ripeto, ho deciso, per un paio di settimane, di non ascoltare chi sosteneva il contrario? E di considerarlo, se non pazzo, almeno esagerato? Mi sono data, anche grazie al libro di Giordano, una risposta. Abituata a pormi obiettivi costanti, presa dalla frenesia del lavoro, impegnata a incastrare professione, vita privata e affetti, se ho deciso che devo andare da A a B in un tempo X, non riesco a immaginare nessun intoppo che implichi un tempo X+1 né tantomeno che, nel percorso da A a B, qualcosa di imprevisto comporti un arresto in un punto intermedio. Tanto più se questo qualcosa non ha a che fare – almeno apparentemente – con me e la mia volontà. Ecco: la mia volontà. La presunzione – stupida – che immagino sia legata al nostro costante correre e programmare e conseguentemente all’incapacità (o impossibilità a volte) di fermarci, è pensare che la mia volontà imponga una necessità alle cose. Affinché il mio percorso da A a B non sia intralciato io esigo, voglio, e mi servo ancora delle parole di Giordano, «che il contagio finisca tra una settimana, che si torni alla normalità». E ci credo, anche.
Sono abituata a fare tutto, sempre e comunque. Mi giudico negativamente se non riesco a farlo. Il giudizio che esprimo su di me quasi dipende dal livello delle mie performance. Fermarsi, quindi, coincide con la resa. La rinuncia è lo smacco. Ma qui sta l’errore. Credo di averlo capito in queste settimane. Desidero che diventi consapevolezza interiorizzata. Il 28 febbraio prendevo i mezzi con la mascherina, ma poi arrivavo in un teatro gremito, dove la toglievo; incontravo due amici, senza baciarli, ma poi tutti e tre insieme andavamo in una pizzeria altrettanto affollata. Orgogliosi di farlo, di non mostrare timore. Non voglio che accada più. A volte ci si deve fermare. Non farlo è stato un atteggiamento sconsiderato ed egoista. Sul tema egoismo tornerò.
2.«Non mi lascerò determinare. Non permetterò ad alcun virus di interrompere la mia socialità». (p.24) Su questa questione prendo spunto dalle parole di Giordano, che sottolineano come la quarantena ci abbia relegati a una solitudine improvvisa e difficile da gestire, per sollevare però a mia volta un altro tema. Come è possibile che da subito, di fronte all’invito/imposizione di rimanere a casa, si sia scatenato il panico? Non avendo vissuto questo stato d’animo (mi sono sentita bene a casa e continuo a non provare disagio nel trascorrere del tempo qui, un tempo per me stessa e con me stessa), provo a fare da osservatore esterno: perché non riusciamo più a stare da soli? Perché le nostre case, anche se belle, ci provocano disagio? Perché liste su liste di cose da fare per sfuggire a questo horror vacui? Capisco il disagio di dover gestire figli in casa, tanto più se piccoli. Mi sforzo di comprendere altri malesseri. È vero, l’uomo è un animale sociale. Ma esiste solo sulla base di questa socialità e comincia a mostrare fastidio e sofferenza appena quella abituale convivenza si interrompe? Il non riuscire – da subito – a stare bene con sé stessi può allora indurre a qualche considerazione. A chiedersi perché accada. Il tempo concessoci – almeno fino a quando non è stato attraversato da preoccupazioni lavorative – non avrebbe potuto essere vissuto come un tempo ritrovato? Come un momentaneo privilegio? Come il tempo – quello che non abbiamo davvero mai – per fermarci a pensare, ad ascoltare questi pensieri – spesso brandelli inafferrati in mezzo al fluire rapido delle nostre vite – a esporli a qualcuno che abbia a sua volta il tempo di ascoltarli? Lamento spesso la mancanza di tempo per pensare, avvertendola come una grave perdita. In queste settimane – vissute in una lontananza forzata e spiacevole dagli altri – a me pare di aver sperimentato almeno il privilegio di tornare a pensare, e a farlo con i tempi di cui la riflessione ha bisogno. Non voglio scordarmi che negarmi quel diritto era una rinuncia troppo grande.
3.«La decisione migliore non è quella che è presa in base al mio tornaconto esclusivo. Quindi l’epidemia ci incoraggia a pensarci come appartenenti a una collettività» (p.26-7). Giordano presenta la scelta di non uscire dalle nostre case anche in termini di valutazione costi-benefici (mai usando questa espressione) e a me sembra il modo migliore per cercare di convincere tutti della necessità di questo comportamento. La mia personale rinuncia a espormi non solo protegge me, ma protegge anche gli altri: impedirà che altri si infettino e che a loro volta infettino altri. Il contagio ci ha fatto scoprire quanto le nostre azioni incidano direttamente sugli altri e quanto, quindi, vadano controllate anche per non nuocere agli altri. Questo secondo me è il tema più urgente che l’emergenza sanitaria ha messo a nudo: non siamo comunità, non siamo collettività. Lo siamo solo se costretti.
Per indole sono portata a combattere spesso battaglie solitarie suscitando la derisione di molti: per far togliere l’erba alta dalle mura aureliane, per salvare gli olmi dai parassiti che li uccidono e che poi invadono le nostre case, per far rimuovere auto in seconda fila o sul marciapiede… La lista è lunghissima. Accetto la derisione, bonaria o meno, e vado avanti. Quello che mi dico sempre è che se fossimo uniti nella protesta, lo sforzo e le energie impiegati sarebbero notevolmente minori. Non siamo comunità, non siamo quasi mai in grado di agire in modo eterodiretto e altruista, a muoverci deve essere sempre qualcosa che ci riguardi. E questa mancanza di altruismo, nella situazione odierna, ci ha portato a commettere errori gravi, che si sono ripercossi su tutti, che ci hanno danneggiato anche personalmente. Fare qualcosa solo per l’altro ci è quasi impossibile. A tal punto che non ci riusciamo nemmeno se agire per l’altro gioverà anche a noi. Giordano parla anche di una “ragione umana” che avrebbe dovuto e dovrebbe spingerci a stare a casa: proteggere coloro che sono “ultrasuscettibili” di ammalarsi, gli anziani. In Italia, a quanto pare – come ha sostenuto freddamente Luttwak in una recente trasmissione – ce ne sono molti, grazie al fatto che ce ne siamo presi cura. Negli usa, il sistema sanitario, per la sua natura “commerciale”, non lo ha fatto e così, ad ammalarsi tra gli anziani saranno solo i ricchi… perché gli altri non ci sono più. (Questa considerazione si è impressa nella mia mente da quando l’ho sentita e non accenna ad andarsene). La ragione “umana” però, che personalmente trovo quasi sempre cogente, spesso non lo è per i più. E allora, mi chiedo, una volta fuori dal contagio, come potremo convincerci – molto pragmaticamente – che l’altruismo è la strategia vincente? Il SARS-Cov-2 ci ha messo in fondo di fronte a un fatto: individualismo sfrenato ed egoismo sono insostenibili. Voglio ricordamene ancora di più di quanto faccio, una volta finito questo periodo. Voglio ricordarmi sin d’ora che a uscire con le ossa rotte da questa crisi non sarò io, o almeno non lo sarò quanto chi viveva con gravi problemi economici già prima. Adesso le nostre donazioni vanno agli ospedali, poi dovranno andare a loro: voglio ricordarmi che curarmene sarà mio dovere, umano, se mi piacerà considerarlo tale, o di altro genere, se non vorrò farne una questione di umanità.
In questo modo avrò – come suggerisce Giordano – attribuito «un senso al contagio», (p.63) sarò diventata più consapevole che esiste una «responsabilità allargata alla quale nessuno può sottrarsi» (p.32) e forse, di fronte al ripresentarsi di un evento altrettanto tragico, sarò un essere umano e un cittadino migliore. O forse solo più capace e accorto. Ma basterebbe.
Alessandra Penna


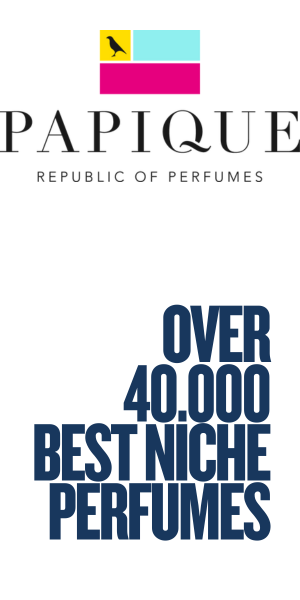


There is 1 comment on this post
Comments are closed.