
In spiaggia, sotto gli occhi di tutti, un padre picchia la figlia. Un gesto “normale”, ancora oggi. Proviamo a capire insieme perché.
L’educazione non passa attraverso la violenza. La violenza e le punizioni sono ancora considerate un modo di educare. Ma questa forma mentis non è solo inefficace: è pericolosa. Eppure, chi prova a cambiare strada si ritrova spesso solo, giudicato, ostacolato. Serve una rivoluzione culturale, supportata dalla legge.
Quest’estate ho potuto godere delle spiagge meravigliose delle coste italiane e mi sono resa conto che in spiaggia più che mai le persone hanno voglia di raccontarsi, tra un bagno e un castello di sabbia mi sono immersa nell’ascolto e nell’osservazione.
Ma c’è stato un episodio che mi ha profondamente turbata, lasciando un’impronta che ancora oggi mi scuote e mi fa provare una profonda indignazione. Un padre, tirando sua figlia per un braccio, la colpiva ripetutamente sul sedere. Lei singhiozzava, urlava. La madre gridava il nome del padre, lo implorava di smettere, gli correva dietro. In un istante il mio corpo ha reagito prima della mia mente.
Ho iniziato a correre verso di loro. Forse perché quelle immagini risvegliavano ricordi antichi, scene viste e vissute. Perché anche io sono cresciuta in una cultura dove la punizione fisica era accettata. Le “botte a fin di bene”: che ossimoro grottesco. Una volta lì, l’unica cosa che ho trovato la forza di dire è stata: “Picchiare i bambini è illegale. È vietato dalla legge.” I genitori mi hanno congedata in fretta con un “Grazie, grazie”, e un gesto secco per invitarmi ad andarmene.
La tradizione della violenza.
Questo episodio mi ha scatenato dentro rabbia, tristezza e rivolta.
Rabbia. Perché la violenza sui bambini è ancora considerata, da molti, una componente “normale” della crescita.
Perché si confonde l’educazione con la sottomissione, il rispetto con la paura. Le cosiddette violenze ordinarie — pizzichi, schiaffi, punizioni d’isolamento, urla — sono ancora terribilmente diffuse. In Italia, secondo un’indagine nazionale dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), i casi di maltrattamento sono aumentati del 58% negli ultimi cinque anni, e nell’87% dei casi gli autori sono membri della famiglia. E queste sono solo le statistiche basate sui minori entrati in contatto con i servizi sociali.
Ma quanti sono i bambini che, ogni giorno, vivono le cosiddette violenze ordinarie tra le mura di casa? In Francia, un bambino su tre in ogni classe ne subisce quotidianamente.
“Il bambino maltrattato ama i suoi genitori più di se stesso.”
Alice Miller, “Il dramma del bambino dotato”
L’amore incondizionato del bambino verso chi lo cresce non cancella il danno, lo nasconde. Le punizioni corporali non insegnano nulla: feriscono, umiliano, spezzano la fiducia. E lasciano cicatrici profonde, che si manifestano in età adulta come insicurezze, dipendenze, aggressività.
Il regista Michael Haneke, nel suo film Il nastro bianco, ci mostra come un’intera generazione cresciuta con freddezza, umiliazione e castigo sia poi diventata terreno fertile per l’ideologia nazista. La violenza educativa, se tollerata, costruisce società autoritarie.
Il paradosso della nostra epoca.
Provo tristezza, perché viviamo in un’epoca di lotta per i diritti civili, contro la violenza sulle donne e sulle minoranze. Ma picchiare un bambino sembra ancora socialmente accettabile, persino difendibile. Vedere un uomo alto quasi due metri, adulto, scaricare la sua frustrazione su una bambina di sette anni, piccola e indifesa, mi paralizza. Non esiste motivazione che giustifichi una tale sproporzione di potere e violenza.
“Il bambino è una persona.”
Françoise Dolto
Dolto è stata la prima voce negli anni 70 che ha rivoluzionato e denunciato l’educazione di sottomissione di quell’epoca proponendo nuove forme di relazione con i figli.La Dolto sostiene infatti che fin dalla nascita, il bambino è un soggetto. Non un contenitore vuoto da riempire, né un animale da ammaestrare. È un essere umano che merita rispetto, parola, ascolto. La violenza e la sottomissione, invece, lo riducono al silenzio.
Dopo la rabbia e la tristezza è arrivata ancora più forte la rivolta. La rivolta verso il silenzio collettivo. Il suono degli schiaffi rimbombava sulla spiaggia, eppure nessuno è intervenuto. Nessuno ha chiesto se la bambina stesse bene. Mi sono chiesta: e se quell’uomo avesse avuto lo stesso comportamento verso la moglie? Le reazioni sarebbero state le stesse? Probabilmente no.
C’è ancora l’idea che i bambini appartengano ai genitori. Che chi li cresce abbia diritto anche di colpirli, se “serve”. Ma la violenza sui bambini non è mai un affare privato. È una questione pubblica, educativa, culturale.
La mia rivolta si alimenta ogni giorno leggendo gli articoli di giornale in cui vedo i nostri politici battersi per impedire che le lezioni di educazione alla vita affettiva, relazionale e sessuale entrino stabilmente nelle scuole. E questo accade in un Paese in cui ragazze e donne muoiono ogni giorno, dove la violenza ordinaria sui bambini è quotidiana. L’insegnamento di valori e principi deve partire anche dalle scuole: la rivoluzione culturale deve nascere nei luoghi dove i bambini sono tutti uguali.
Se l’87% dei maltrattamenti avviene all’interno della famiglia, è evidente che l’educazione contro queste forme di violenza non possa essere demandata alla famiglia stessa. Queste lezioni non sono fondamentali solo per aiutare a far evolvere le menti dei giovani potenziali futuri aggressori, ma lo sono ancor di più perché le potenziali vittime — bambini e adolescenti che subiscono violenze fisiche o psicologiche — possano riconoscersi come tali, comprendere che ciò che subiscono è una violenza, sapere che hanno il diritto di ribellarsi, di chiedere aiuto, e imparare come e a chi rivolgersi.

L’educazione positiva.
Mi sconvolge constatare come, spesso, la società giudichi più severamente i genitori che, con fatica, cercano di praticare un’educazione rispettosa. Genitori che scelgono di accogliere un pianto invece di reprimerlo, che si impegnano a usare parole giuste, a riconoscere nei bambini persone complete, non “quasi umani” da ammaestrare.
Siamo la prima generazione di genitori a tentare di educare in modo diverso da come siamo stati cresciuti. Ma inventare una nuova forma di genitorialità è difficile — e senza supporto, ancora di più. È molto più semplice tramandare ciò che ci è stato insegnato, trasmettere tutto il bagaglio di traumi, mancanze e disattenzioni. Creare un nuovo modo di essere genitori è complesso: ascoltare un bambino, aiutarlo, considerarlo, accompagnarlo, offrirgli gli strumenti per diventare se stesso nell’amore e nella comprensione richiede impegno e costanza.
Soprattutto in una realtà sociale in cui la comunità non esiste più, dove la famiglia allargata, i vicini, l’aiuto reciproco sono stati sostituiti da un crescente individualismo, lasciando i genitori sempre più soli. Come ha scritto lo psicoanalista Daniel Stern: “L’esperienza soggettiva del bambino è al centro del suo sviluppo.” Se non la riconosciamo, se la calpestiamo, stiamo crescendo adulti feriti.
E la legge?
A oggi, più di 68 Paesi hanno vietato esplicitamente le punizioni fisiche sui bambini. La Svezia è stata la prima nel 1979. Il più recente è il Tagikistan, nel 2024. In Francia, la legge contro le “sculacciate” è in vigore dal 2019. In Italia, ancora nulla di esplicito. Attualmente, ci si rifà all’art. 571 del Codice Penale, che punisce chi abusa dei mezzi di correzione.
Ma per anni questa norma è stata interpretata in modo ambiguo, giustificando le punizioni corporali. Solo nel 1996 la Corte di Cassazione ha stabilito che “l’uso della violenza, anche se moderata, nei confronti dei figli non è ammissibile”, poiché incompatibile con i valori di una società democratica fondata sulla dignità della persona.
Essere genitori è il compito più difficile che esista.
La nascita di un figlio smuove tutto: ci riporta a ferite antiche, ci fa ripetere gesti subiti, parole ascoltate. Diventare genitori è un viaggio che ci mette a nudo: ci mostra il meglio di noi — e il nostro lato più buio. Ogni giorno si combatte con stanchezza, rabbia, frustrazione.
Ma mai, in nessuna situazione, la risposta può essere: “Solo una sculacciata”. La violenza non educa. Distrugge. Segna. Si trasmette.
Se vogliamo davvero un mondo con più giustizia, più rispetto, più diritti, allora l’educazione non può più passare dalla paura. Il ruolo dei genitori è fondamentale. Ma devono essere sostenuti, non lasciati soli. Servono strumenti, reti, formazione. Serve uno sguardo politico sulla genitorialità. Non bastano buone intenzioni. Servono scelte collettive.
La mia corsa per fermare quella violenza non cambierà il corso degli eventi, ma almeno quella bambina ha sentito che ciò che le stava accadendo era un’ingiustizia.
Ha sentito che la rabbia e la tristezza che provava erano giuste, che appartenevano al suo diritto di essere vista, di essere ascoltata. E in quel gesto ho difeso anche la bambina che sono stata. È stato un atto di guarigione, un abbraccio dato nel tempo, una carezza che ha attraversato gli anni per raggiungermi.
Ci vuole coraggio.
Il coraggio di dire basta.
Di non distogliere lo sguardo.
Di proteggere i bambini. Sempre.
Entra nella nostra community clicca qui: Newsletter
Sostienici, clicca qui: PINK


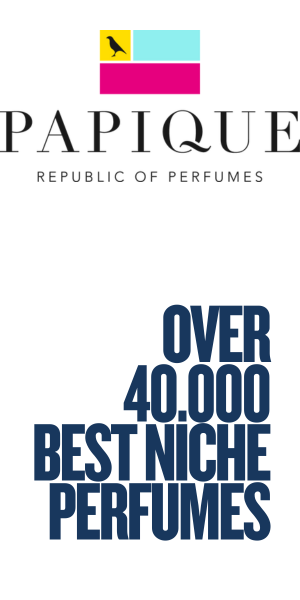


Comments are closed.