
Nella scorsa “puntata” (che trovate qui) abbiamo ripercorso alcuni tratti salienti delle città e della cultura afghana attraverso il best seller Mille splendidi soli di Khaled Hosseini.
Herat, Kabul, le donne: luoghi e argomenti di forte attualità e di grande intensità, che ci permettono di compiere un viaggio letterario dall’altra parte del mondo (ma non del tempo, a quanto pare, purtroppo).
In questa seconda parte proseguiamo il nostro viaggio partendo da uno dei siti storici e archeologici più importanti al mondo, divenuto tristemente famoso dopo la sua distruzione da parte dei talebani.
LA PROVINCIA AFGHANA
E’ il 1987 e Laila è una bambina felice di nove anni. Il padre decide di farle fare un viaggio a sorpresa: c’è assolutamente qualcosa che lei e il suo amico Tariq devono vedere con i loro occhi.
“Laila vedeva il paesaggio trasformarsi sotto i suoi occhi: dalle cime innevate ai deserti, ai canyon, alle catene rocciose bruciate dal sole. Lungo la strada incontrarono case di mattoni crudi con il tetto di paglia e campi disseminati di covoni di grano. Qua e là, piantate su terreni polverosi, Laila scorgeva le tende nere dei nomadi kuci. E le carcasse di carri armati e di elicotteri sovietici abbattuti“.
“Qui, nelle province, la guerra si combatteva sul serio. Non a Kabul. Kabul era una città che viveva prevalentemente in pace. A Kabul, a parte le sporadiche sparatorie, a parte i soldati sovietici che con la sigaretta in bocca pattugliavano i marciapiedi e le jeep sovietiche che scorrazzavano incessantemente per le strade, la guerra avrebbe potuto sembrare una semplice diceria”.
I BUDDHA DI BAMIYAN
“Scesero dal taxi. ‘Eccoli’ disse Babi indicandoli. Tariq rimase a bocca aperta. Anche Laila era senza parole. Fosse vissuta cent’anni, non avrebbe mai visto niente di così stupefacente. I due Buddha erano enormi, molto più alti di quanto li avesse immaginati guardando le foto. Scolpite nella parete rocciosa sbiancata dal sole, le due statue li scrutavano dall’alto, come quasi duemila anni prima avevano scrutato le carovane che attraversavano la valle lungo la via della seta. Su ciascun lato, al di là della nicchia da cui i Buddha erano protetti, la rupe era traforata da una miriade di caverne”.
“Mentre continuavano la scalata, Babi raccontò loro che un tempo Bamiyan era stato un fiorente centro buddhista, finché nel nono secolo non era caduto in mano agli arabi. Le pareti d’arenaria erano abitate da monaci buddhisti che vi avevano scavato grotte usate sia come abitazioni sia come templi per alloggiare i pellegrini. I monaci, disse Babi, avevano dipinto dei meravigliosi affreschi sulle pareti e sui soffitti delle loro celle. ‘C’è stato un momento in cui, in queste grotte, vivevano in eremitaggio cinquemila monaci’, spiegò”.

LA VALLE DI BAMIYAN
“La valle di Bamiyan era tappezzata di fertili campi coltivati. Babi spiegò che le coltivazioni che vedevano erano grano invernale, erba medica, ma anche patate. I campi erano delimitati da filari di pioppi e attraversati da torrenti e canali d’irrigazione, sulle cui rive erano accucciate minuscole figure femminili intente al bucato. Babi indicò le risaie e i campi di orzo che coprivano i pendii.
Laila riusciva a distinguere i contadini che, nelle loro tuniche dai colori sgargianti, stendevano il raccolto ad asciugare sul tetto delle case in mattoni crudi.
Anche la via principale che attraversava il villaggio era bordata di pioppi. Sui due lati c’erano botteghe, piccoli locali dove si serviva il tè e barbieri che tagliavano barba e capelli per la strada. Al di là del villaggio, al di là del fiume e dei torrenti, Laila vedeva delle basse colline brulle, di un marrone polveroso, e, al di là delle colline, come al di là di ogni cosa in Afghanistan, si ergeva l’Hindu Kush dalle cime coperte di neve. E sopra ogni cosa si estendeva il cielo di un azzurro perfetto, immacolato”.
Nella terza parte del libro Laila e Mariam, loro malgrado, si conoscono e iniziano a convivere insieme.
E’ il 2001 e Laila ha quasi ventitré anni quando
“aveva saputo che i talebani avevano collocato cariche di tritolo nelle crepe dei colossali Buddha di Bamiyan e li avevano fatti saltare in quanto oggetto di peccato e di idolatria. Il mondo intero, dagli Stati Uniti alla Cina, aveva protestato indignato. Governi, storici, archeologi di tutto il mondo avevano scritto lettere, avevano scongiurato i talebani di non distruggere i due più grandi monumenti storici in Afghanistan.
Ma i talebani avevano portato a termine la loro opera, facendo saltare l’esplosivo nei Buddha antichi di duemila anni. A ogni detonazione avevano gridato ‘Allah-u-akbar’, esultando ogni volta che le statue perdevano un braccio o una gamba in una polverosa nube di macerie. Laila ricordava quando, nel 1987, con Babi e Tariq era salita sulla testa del Buddha più grande… Ma Laila aveva accolto la notizia della distruzione delle statue con indifferenza. Non le sembrava una cosa così importante. Come poteva preoccuparsi di statue, ora che la sua stessa vita si stava sgretolando?”.
KABUL, INVERNO 1992
E’ sempre nella terza parte del libro che le due donne si ritrovano a vivere nell’amata Kabul dilaniata dalle guerriglie tra gli hazara e Hekmatyar, quest’ultimo appoggiato dai pakistani, contro Massud e Sayyaf, affiancati dal comandante uzbeko Dostum.
“Dapprima gli alberi – quelli che non erano stati tagliati per fare legna da ardere – lasciarono cadere le foglie chiazzate, gialle e rosso rame. Poi la città fu spazzata da venti freddi e pungenti, che lasciarono gli alberi nudi e spettrali sullo sfondo bruno opaco delle colline. La prima nevicata della stagione fu leggera, i fiocchi si scioglievano non appena toccavano il terreno. Poi le strade ghiacciarono e la neve si ammucchiò sui tetti delle case, si accumulò contro le finestre coperte di ghiaccio. Con la neve arrivarono gli aquiloni, un tempo dominatori dei cieli invernali di Kabul, ora timidi intrusi in spazi occupati dai lanci dei razzi e dai voli dei caccia”.
“A Kabul, soprattutto nella zona occidentale della città, imperversavano gli incendi e luttuosi funghi di fumo nero incappucciavano gli edifici coperti di neve. Le ambasciate chiudevano. Le scuole erano al collasso. Nelle sale d’attesa degli ospedali … i feriti morivano dissanguati. Nelle sale operatorie, braccia e gambe venivano amputate senza anestesia”.
“Quell’inverno, dovunque andasse, Laila incontrava muri che le sbarravano la strada. Pensava con nostalgia ai grandi cieli liberi della sua infanzia, ai giorni in cui andava con Babi ai tornei di buzkashi o con la mamma a far compere a Mandaii, ai giorni di corse sfrenate per le strade, quando con Giti e Hasina spettegolava sui ragazzi. Ai giorni in cui lei e Tariq si sedevano in un prato di trifoglio sulle rive di un torrente, scambiandosi indovinelli e dolci e guardando il sole che tramontava”.
KABUL, SETTEMBRE 1996
“Da due anni i talebani cercavano di aprirsi la strada verso Kabul, sottraendo ai mujahidin una città dopo l’altra, stroncando la guerra delle fazioni dovunque si insediavano”.
“Kabul fu invasa dai camioncini dei talebani… Toyota rossi scorrazzavano epr le strade, carichi di uomini barbuti in turbante nero. Su ogni pick-up, un altoparlante trasmetteva annunci a tutto volume, prima in farsi poi in pashtu.
Lo stesso messaggio risuonava dall’alto delle moschee e veniva trasmesso alla radio, che ora si chiava La Voce della Sharia. Il comunicato era scritto anche su volantini che venivano lanciati per le strade”.
L’Emirato Islamico dell’Afghanistan, oltre a dettare leggi precise per tutti i cittadini e i fedeli, così minacciava le donne:
“Donne, attenzione: dovete stare dentro casa a qualsiasi ora del giorno…
Se uscite, dovete essere accompagnate da un parente di sesso maschile.
La donna che verrà sorpresa da sola per la strada sarà bastonata e rispedita a casa.
Non dovete mostrare il volto in nessuna circostanza.
Quando uscite, dovete indossare il burqa. Altrimenti verrete duramente percosse.
Erano da quel momento proibiti i cosmetici, gli smalti per le unghie, i gioielli. Tutti gli “abiti attraenti”, il parlare o il ridere in pubblico. Era ammesso solo rispondere se interpellati, e senza mai guardare negli occhi gli uomini. Ovviamente, tutte le scuole femminili erano state immediatamente chiuse, nessuna bambina poteva avere un’istruzione pubblica né ad alcuna donna era più permesso lavorare. Le pene, svariate, andavano dalle bastonate, al taglio delle dita delle mani, alla lapidazione in caso di adulterio.
“Uomini armati di asce invasero il dilapidato museo di Kabul e fracassarono le statue pre-islamiche rimaste nelle teche dopo i saccheggi dei mujahidin. L’università venne chiusa e gli studenti rispediti a casa. I quadri vennero staccati dalle pareti e le tele squarciate a coltellate. Gli schermi dei televisori furono presi a calci.
Mucchi di libri, tranne il Corano, vennero dati alle fiamme. Le librerie furono chiuse. … Ovunque, i camioncini Toyota della Pattuglia della Barba perlustravano le strade alla ricerca di facce rasate da trasformare in maschere di sangue… Chiusero anche i cinema. Presero d’assalto le sale di proiezione e bruciarono le pellicole”.
“Kharabat, l’antico ghetto musicale di Kabul, fu ridotto al silenzio. I musicisti vennero bastonati e imprigionati e i loro rubab, tambura e armonium distrutti a calci”.
KABUL, APRILE 2003
Nella quarta e ultima parte del libro finalmente, dopo tanto dolore e sofferenze, possiamo aggrapparci ad uno spiraglio di luce.
Dopo molte sventure, ma anche dopo una grande e immensa gioia, Laila torna nella sua Kabul liberata dai talebani.
“A Laila sembra strano trovarsi di nuovo a Kabul. La città è cambiata. Ogni giorno vede gente che mette a dimora nuove pianticelle, ridipinge le vecchie case, porta mattoni per costruirne di nuove. Si scavano canaletti di scolo e pozzi. Sui davanzali Laila vede fiori interrati in vasi ricavati dai gusci vuoti dei razzi dei mujahidin – i Fiori dei Razzi, li chiamano gli abitanti di Kabul. … Per la prima volta dopo anni Laila sente musica agli angoli delle strade: rubab e tabla, dutar, armonium e tambura…”.
Alla fine del libro ci sentiamo come Laila nel suo ultimo viaggio in taxi, quando, ascoltando la storia dell’autista dal lontano 1979, poco prima dell’invasione sovietica, pronuncia un timido “Mi spiace” e al contempo, pensando, si meraviglia
“di come la storia di ogni afghano sia segnata dalla morte, dal lutto e da inimmaginabile dolore. E tuttavia, vede che la gente trova un modo di sopravvivere, di tirare avanti. Pensa alla propria vita e a quanto le è accaduto e si stupisce di essere sopravvissuta, di essere ancora viva, seduta in quel taxi, ad ascoltare la storia di quell’uomo”.


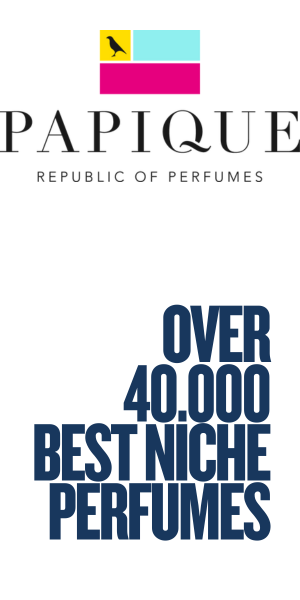


There are 3 comments on this post
Comments are closed.