
Tratto da una storia vera, il nuovo film di Magnus von Horn presentato a Cannes ci porta nella Danimarca degli anni ’20. Una visione che disturba ma non riusciamo a distogliere gli occhi tanto sono straordinarie le interpretazioni, soprattutto quelle femminili.
Bisogna stare attenti con gli aghi: strumenti taglienti, di piccole o medie dimensioni, possono incidere quanto una spada, o si possono anche rompere. Vanno maneggiati con cura. Così come il film, La ragazza con l’ago, in concorso a Cannes per la Palma d’Oro, richiede una certa attenzione, e una certa meticolosità, sia nel guardarlo, sia nel parlarne. Ed è un film che farà parlare – perché è un film che scuote, incide e trafigge. Il regista svedese Magnus von Horn tesse un ritratto cruento, spaventoso, allucinante, di due donne nella Danimarca post bellica. Il cinema del nord è noto per i suoi inizi ad effetto (Bergman, Dreyer); von Horn ci mette subito in guardia, aprendo con una sequenza di volti che si deformano contro uno sfondo nero: non sarà una visione facile.
Ispirandosi alla storia vera di un’assassina seriale infanticida, von Horn ci porta negli anni ’20. Per farlo al meglio, sceglie il bianco e nero. (E viene da pensare a Elephant Man di Lynch, o anche a Cold War di Pawlikowski.) La prima guerra mondiale sta finendo; la Danimarca, così come l’Europa intera, è un paesaggio di fango dove donne e bambini sono la presenza dominante.
Giovani madri
Karoline è una giovane ragazza rimasta solo dopo la guerra: il marito non è mai tornato. Ha uno sguardo perso e le sue smorfie infantili sono l’espressione di un mondo interiore che non trova spazio nella realtà esterna. Lavora come tessitrice e quando viene sfrattata di casa dal proprietario perché non riesce più a pagare l’affitto, chiede aiuto al suo capo di lavoro. Sembra gentile e premuroso e le promette che cercherà di scoprire che fine abbia fatto suo marito. Queste attenzioni diventano presto anche fisiche e Karoline resta incinta. La distanza sociale non permette un’unione serena tra i due e la giovane decide di liberarsi del feto, nei bagni pubblici… Le basta un ago. Ma una donna si intromette, è materna, ha dai lineamenti forti e l’aria bonaria, come fosse un angelo custode (è Trine Dyrholm, che buca lo schermo); fa di tutto per salvare il bambino promettendole che alla sua nascita gli troverà una famiglia benestante a cui affidarlo.
Comincia così l’amicizia tra queste due donne, agli antipodi l’una dall’altra. Ma, l’apparenza inganna. I volti, così come i luoghi cominciano a deformarsi sotto l’effetto della morfina, tranquillizzante di cui le due insieme, fanno uso quotidiano. E come gocce che cadono in un piatto, una dopo l’altra, in un ticchettio costante che si ripete, Karoline viene trascinata in una follia che non poteva prevedere.
Il marito della giovane torna dalla guerra deformato. Utilizza una maschera per coprire il suo viso. È questo il contesto storico e sociale nel quale ci troviamo: lo vediamo sul suo volto.
Dal passato al presente
La visione sconcertante che propone questo film ci turba ancor più quando ci rendiamo conto che quel passato fa ancora parte del nostro presente. E non stiamo parlando solo di guerre ai confini dell’Europa; pensiamo ad Alessia Pifferi, condannata solo pochi giorni fa all’ergastolo per aver lasciato morire di fame la figlia. Nel film la maternità viene affrontata sotto una lente d’ingrandimento deformante ma non si tratta mai di violenza gratuita sullo spettatore. Questa follia, fisicamente dolorosa, è una delle esperienze cinematografiche più intense degli ultimi anni.


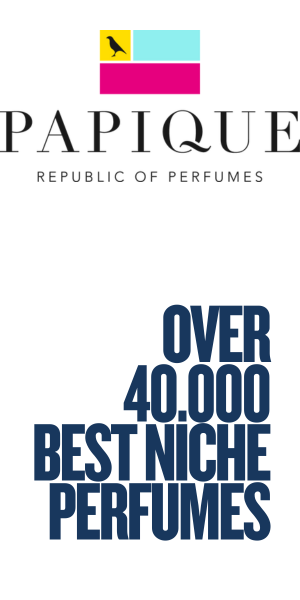


Comments are closed.